Ricordo con simpatia il grande Alberto Sordi ne “Il Marchese del Grillo”, quando, dinanzi al lavoro reso dal mirabile ebanista Aronne Piperno … armadi, cassapanche, mobili finemente realizzati … si rifiutava categoricamente di pagare la prestazione resa dal povero artigiano, opponendo, a giustificazione del mancato pagamento, presunti inadempimenti di carattere “religioso”, oggetto di scherno e dileggio.
“Ma io c’ho ragione!”, evidenziava il mite ebanista.
“E vabbè, se i giudici te la danno io te pago… adesso famme annà a dormì, che sò stato in piedi tutta la notte!”, replicava con sicumera il saccente Marchese.
Forse quella era una delle prime applicazioni del principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Applicazione, peraltro, assolutamente abusiva, errata, ma giustificata dal tono scherzoso della commedia.
Peraltro il buon Marchese aveva modo di porre rimedio allo scherno e premiare l’ebanista dopo la bravata compiuta!.
Ma cosa significa “inadimplenti non est adimplendum”?
L’ordinamento tutela le parti contrattuali, la cui controparte si renda inadempiente nell’esecuzione della prestazione concordata: tu non mi paghi il prezzo ed io non ti consegno il bene compravenduto; tu non provvedi a dare seguito al servizio concordato ed io non ti corrispondo il compenso pattuito; tu non mi consegni la spedizione richiesta, ed io non pago la fattura trasmessa.
Dunque una parte contrattuale, nel momento in cui l’altra parte si rende inottemperante ai propri obblighi e, pur tuttavia, per ipotesi esiga l’esatto adempimento della controprestazione, ha diritto di eccepire, a sua volta, l’inadempimento, negando quanto contrattualmente dovuto.
Si tratta dell’eccezione di inadempimento, ben conosciuta come principio di autotutela, o anche con il brocardo “inadimplenti non est adimplendum” (letteralmente: a chi è inadempiente non è dovuto l’adempimento).
Il codice civile italiano all’interno dell’art. 1460 statuisce che ciascuno dei contraenti di un contratto a prestazioni corrispettive, ben può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, qualora la controparte non adempia, oppure non offra di adempiere contemporaneamente la propria, a meno che siano previsti tra le parti dei termini diversi per l’adempimento, o tale differenza temporale nell’esecuzione delle rispettive prestazioni risulti dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può essere rifiutata l’esecuzione della prestazione qualora, avuto riguardo alle circostanze, il suo rifiuto sia contrario alla buona fede contrattuale (ossia quando non risulti giustificato da un inadempimento non lieve dell’altra parte: si pensi ad un inadempimento di scarsa importanza e dalle dimensioni minimali, come il mancato pagamento di una parte minima e non economicamente influente, di un rateo della bolletta della luce, che determina, inopinatamente ed abusivamente, in capo alla società erogatrice del servizio, la sospensione della fornitura di elettricità. In tale caso, la società fornitrice deve risarcire il danno cagionato e provvedere all’immediato e completo riallaccio dell’utenza).
Per costante giurisprudenza, la valutazione di tutti gli elementi della complessa fattispecie, ivi compresa la gravità del dedotto inadempimento e la buona fede di colui che si avvale dell’eccezione, deve essere compiuta dal giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
L’eccezione di inadempimento è prevista anche nel diritto internazionale: l’art. 60 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (sul Diritto dei Trattati) statuisce che una violazione sostanziale di un trattato bilaterale, posta in essere ad opera di una delle parti, legittima l’altra parte ad invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato, o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.

Quando un lavoratore può rifiutare la propria prestazione nei confronti del datore di lavoro?
Anche nel mondo del lavoro vige il principio “inadimplenti non est adimplendum” in quanto il contratto di lavoro è a prestazioni corrispettive e, facendo fede al dettato dell’art. 1460 del codice civile, sono state enucleate dalla giurisprudenza, diverse fattispecie legittimanti l’eccezione di inadempimento.
La Suprema Corte ha evidenziato, in ogni caso, che il diniego opposto da un lavoratore subordinato, di svolgere la propria prestazione lavorativa, può dirsi legittimo (e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive), purché il rifiuto di adempiere sia proporzionato all’illegittimo comportamento datoriale, e conforme alla buona fede. Più nello specifico, con la Sentenza n. 1693 del 24 gennaio 2013 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha rilevato che il giudice, nel momento in cui sia proposta dal lavoratore l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, è tenuto ad operare una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto di lavoro ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse; qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave, ovvero riveste caratteri minimali e scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato, ai sensi dell’art. 1460 comma 2 del codice civile.
Ad esempio, il rifiuto dell’adempimento della prestazione lavorativa, o anche il non completo adempimento della stessa, da parte del lavoratore, venendo meno alle modalità di esecuzione delle mansioni disposte dalla controparte datoriale, può esser giustificato nel momento in cui il datore di lavoro ponga in essere misure inidonee per la tutela dell’integrità fisica del proprio dipendente.
In tale contesto, il disposto dell’art. 1460 cod. civ. si combina con quello dell’art. 2087 cod. civ., secondo cui ogni imprenditore deve adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Esemplare, in tal senso, è la Sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte, rubricata al n. 9576 del 9 maggio 2005.
Nel caso di specie, un impiegato alle pulizie e sanificazione di un ospedale, lavoratore di impresa appaltatrice dei lavori di pulimento, si rifiutava di depositare, all’interno dei previsti cassonetti, i cartoni dei rifiuti prelevati dai vari reparti della struttura ospedaliera, in tal modo venendo meno alle proprie mansioni, così come contrattualmente previste ed in spregio delle direttive datoriali. In luogo dello smaltimento presso i cassonetti appositi, il lavoratore in questione provvedeva al depositare il materiale di scarto presso il corridoio adiacente il cortile, presso cui si trovavano i cassonetti.
Evidenziava il dipendente che la condotta “alternativa” rispetto all’esatto adempimento, posta in essere sul luogo di lavoro, null’altro era che l’esercizio del principio di autotutela contrattuale: venivano infatti provate in giudizio le condizioni gravemente fatiscenti ed igienicamente scarse dei cassonetti adibiti all’allocazione del materiale da smaltire (peraltro, secondo quanto emerso in seno all’istruttoria orale svolta in primo grado dinanzi al Tribunale del Lavoro, tramite testimonianze rese da altri lavoratori, si appurava che dai cassonetti fuoriuscivano liquidi fisiologici infetti e maleodoranti, provenienti dalle sale operatorie); su tali basi, era inevitabile la necessità del lavoratore di salvaguardare il proprio diritto alla salute.
Incurante delle giustificazioni addotte dal lavoratore in corso di rapporto, il datore di lavoro provvedeva ad inviare lettere disciplinari al proprio dipendente, comminando diversi giorni di sospensione; alla fine, contestando la recidiva nelle condotte elusive poste in essere dal lavoratore, il datore di lavoro si determinava a comminare il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, eccependone la sproporzione rispetto alla necessità di tutelare il bene salute, superiore rispetto a quello dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa.
Peraltro, provato era anche che il lavoratore, nel rispetto degli obblighi di correttezza nell’esecuzione della prestazione, aveva provveduto ad informare il datore di lavoro circa l’inidoneità dell’ambiente lavorativo in tema di salvaguardia della salubrità e dell’igiene, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile.
La Suprema Corte, all’esito dei tre gradi di giudizio, certificando il valore preminente del diritto alla salute, evidenziava l’illegittimità dell’atto espulsivo, non senza rilevare altresì che il diritto alla tutela della propria integrità psicofisica, da parte del singolo lavoratore, può e deve essere tutelato in via preventiva, qualora la controparte datoriale non fornisca garanzie idonee per uno svolgimento della prestazione all’interno di un luogo di lavoro sano, privo di situazioni pregiudizievoli per la salute o l’incolumità del dipendente.
Sulla scorta di simili postulati, la Suprema Corte è intervenuta in ulteriori casi, ribadendo ancora una volta la legittimità dell’eccezione di inadempimento opposta da lavoratori subordinati.
Ad esempio, con Sentenza n. 6631 del 1° aprile 2015, i Supremi Giudici hanno ritenuto legittima l’astensione di un’ora e mezza dall’esecuzione della prestazione lavorativa, generata da una situazione insostenibile di freddo all’interno dei locali uso ufficio, conseguente al malfunzionamento della caldaia.
Con la Sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013 la Cassazione ha sanzionato, in quanto illegittimo, il licenziamento comminato da un’impresa ad un lavoratore che si rifiutava di svolgere mansioni per le quali aveva preavvertito l’azienda di non essere in possesso delle competenze professionali necessarie, potendo conseguentemente, laddove fosse stato oggetto di assegnazione definitiva, correre il rischio di imbattersi in responsabilità penali, in caso di errore nello svolgimento delle nuove attività richieste.
Con la Sentenza n. 1693 del 24 gennaio 2013 i Supremi Giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore abbandonato dalla controparte datoriale in condizioni di inoperosità, il quale, a sua volta, in ragione di tale stato svilente ed inattivo, non rispettava l’orario di lavoro predefinito.
La Suprema Corte ha ripercorso, in tale pronuncia, la sua giurisprudenza, secondo cui il diniego, opposto dal dipendente, di svolgere la prestazione lavorativa può esser legittimo e, quindi, non giustificare il licenziamento, in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive, sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. Considerato che agire dell’uomo è determinato, pur in limitata misura, dalla situazione esterna nella quale si svolge, ed in particolare dall’altrui comportamento (rispetto al quale possa eventualmente aver costituito reazione), corrisponde ad una necessità logica oltre che giuridica valutare la condotta del lavoratore nel quadro delle condizioni in cui si è svolta: ebbene, concludeva la Suprema Corte, uno stato di forzata inattività imputabile al datore di lavoro, pur senza legittimare un rifiuto del lavoratore di adempiere alla propria prestazione, può tuttavia aver contribuito a determinare una situazione di inadempimento in capo al dipendente e, conseguentemente, ben può essere preso in considerazione per inferirne un ridimensionamento della gravità dell’inadempimento stesso.
Ancora, con Sentenza n. 1912 del 25 gennaio 2017 la Suprema Corte sanziona come illegittima la condotta datoriale estrinsecantesi nell’assegnazione, in capo al lavoratore dipendente, di mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica contrattuale: tale indebita attribuzione può dunque giustificare, per i Supremi Giudici, il rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, purché la reazione posta in essere in “autotutela” sia connotata da caratteri di positività, risultando proporzionata e conforme a buona fede, dovendo in tal caso il magistrato dar seguito ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti.
In sostanza, il requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 comma 2 del codice civile, per la proposizione dell’eccezione di inadempimento, opera quando il diniego opposto dal lavoratore sia stato determinato non solo da un inadempimento grave posto in essere dalla controparte datoriale, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza, che l’art. 1175 del codice civile impone alle parti in relazione alla natura del contratto ed alle finalità da questo perseguite.
Ma in quali casi si eccede nel ricorrere all’autotutela?
Si faccia attenzione: non sempre il brocardo “inadimplenti non est adimplendum” può trovare accoglimento all’interno dell’ordinamento, qualora non sia supportato dai requisiti richiesti dai Supremi Giudici.
Su tali basi, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, rigettando le istanze di una lavoratrice invocante l’eccezione di inadempimento, ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato alla medesima all’esito di un periodo di congedo per maternità, allorquando la dipendente non aveva ripreso a lavorare, adducendo, a propria giustificazione, il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Per i Supremi Giudici il rifiuto di adempiere, come reazione all’inadempimento datoriale, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata: ebbene, il ritardo nel pagamento di una sola mensilità non veniva ritenuto causa sufficiente per dar seguito alla “autotutela”, posta in essere abusivamente e sproporzionatamente dalla lavoratrice.
Quest’ultimo caso impone ulteriori considerazioni: non è escluso che un lavoratore non abbia il diritto di astenersi dal rendere la prestazione in ragione del mancato pagamento delle proprie retribuzioni. Tuttavia, non può dirsi sufficiente che una sola mensilità possa bastare per determinare l’eccezione di inadempimento.
Avv. Alessandro Milanetti
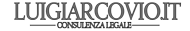 LuigiArcovio.it
LuigiArcovio.it
